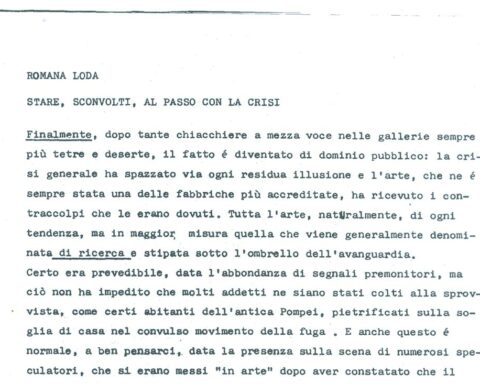Silvio Wolf, Skylight 05, 2002, cm 84×1125, c-print, plexiglas, alluminio. Courtesy Archivio Silvio Wolf.
Francesco Tedeschi
Nel momento in cui si svolge questo incontro, ottobre 2019, ho 57 anni e per ragioni anagrafiche mi sono trovato, come la maggior parte dei presenti, a vivere non solo fra due secoli, come può capitare a una buona percentuale della popolazione mondiale che raggiunga l’età matura, ma anche a cavallo tra due millenni, cosa più rara e che è capitata l’avventura di provare alle generazioni di cui una parte dei presenti fanno parte. Si tratta di una connotazione che si collega alle condizioni storiche e sociali in cui siamo immersi, di cui l’evoluzione tecnologica costituisce un elemento non secondario, sotto il profilo simbolico oltre che su quello pratico.
Ci misuriamo oggi, a questo proposito, con situazioni che ci definiscono e in buona parte ci condizionano, con tutte le opportunità che offrono, ma anche con una serie di servitù che ci impongono.
Per misurare la posizione personale nel tempo e nello spazio uso ripetere un’immagine, che deriva da un semplice calcolo: mi sento e mi sentirò appartenente o più appartenente al Ventesimo secolo finché il tempo di vita che ho trascorso in quel secolo sarà maggiore di quella che avrò vissuta in questo nuovo secolo e millennio. Questo per ridurre a un semplice riferimento quantitativo quello che è prima di tutto un modo di sentire, oltre che un fatto culturale, in quanto il periodo in cui si viene formati e nel quale si trovano i punti di riferimento personali, umani e sociali è quello in cui ci si sente più a proprio agio, l’alveo di partenza, il mondo che si percepisce come familiare, in particolare per chi vive con atteggiamento da “storico” nei confronti delle cose. Questo può tradursi anche in una concezione strettamente legata alla definizione che mi attribuisco in termini professionali, che è di storico dell’arte del Ventesimo secolo, periodo all’interno del quale mi muovo principalmente.
A parte queste valutazioni personali, nel pensare al tema aperto di questo incontro ho ripreso e riprendo una suggestione attorno alla quale, da qualche tempo, vado svolgendo una riflessione articolata, in relazione a immagini e opere che ne esemplificano i contenuti e che ho posto al centro di due corsi tenuti nell’ambito di un percorso di laurea sui “linguaggi dei media”, che sarà a breve pubblicata con il titolo di Luoghi di transizione (1).In questo, guardando all’arte che mi pare meglio interpretare lo spirito dei tempi, mi sono convinto che essa, oltre a raccontare, a volte con estrema attenzione, le vicende che toccano oggi l’umanità, trovi un minimo comun denominatore nel rappresentare il concetto, l’idea e l’immagine del passaggio: da un luogo all’altro, da una condizione all’altra, da un tempo a un altro. Non si tratta forse di una novità o di una peculiarità di questa stagione, ma trovo che sia una condizione che percepiamo oggi in modo particolarmente accentuato.
La situazione esistenziale che più rappresenta il nostro tempo è quella della migrazione, intesa nel suo carattere sociale, umano e individuale, ma da intendersi anche come rappresentazione emblematica di un tempo posto tra due epoche, oltre che della ricerca di un luogo migliore in cui vivere.
A proposito di una lettura del fenomeno antropologico che costituisce il passaggio fra due millenni, e con l’intenzione di spiegare il titolo che ho voluto dare a questo mio intervento, ho pensato a quali analogie possano essere riconosciute fra il recente Duemila e l’anno Mille.
Nel bel saggio dedicato a quell’anno, il 1.000 d. C., alla sua preparazione, alla sua realtà e alle sue conseguenze, Henri Focillon si sofferma sul problema culturale del millenarismo, come fenomeno che non riguarda solo la cultura cristiana, all’epoca nella prospettiva europea pressoché egemone, ma che si ritrova in tutte le tradizioni culturali e religiose: “L’idea della fine del mondo compare presso quasi tutti i popoli antichi come un elemento fondamentale della loro religione o della loro filosofia, come pure l’idea della rinascita gloriosa, nonché il tema della periodicità millenaria: così, nel mazdeismo iraniano, alla fine di undicimila anni, l’inverno e la notte si abbatteranno sul mondo, ma, nel regno di Yima, i morti risuscitano scendendo a ripopolare la terra. Credenze analoghe si ritrovano nell’antica mitologia germanica, in alcune comunità musulmane. La filosofia di Eraclito e la filosofia stoica erano già più o meno impregnate di dottrine analoghe. Nel De natura deorum, Cicerone spiega come il mondo perirà annientato dal fuoco, ma essendo il fuoco anima, essendo Dio, il mondo rinascerà bello come prima. Secondo il millenarismo cristiano, il Cristo deve governare il mondo per un periodo di mille anni – in latino millennium, in greco chiliasmos. Si tratta di un’idea essenziale del cristianesimo primitivo, in cui si perpetua un’antica tradizione giudaica”(2). La lunga citazione vale a mettere in evidenza la prospettiva allargata di una visione che non può essere limitata a una superstizione di un’epoca abbacinata da miti e leggende, ma di una connotazione che si allarga alle diverse visioni dell’uomo e dell’umanità che un’epoca ha profondamente incarnato. Entrando nel merito di quel momento storico, Focillon si sofferma in primo luogo sulle “paure” che hanno caratterizzato quel tempo e che hanno determinato i caratteri degli sguardi che si sono spinti oltre di esso (3). Lo studioso francese osserva anche che ogni forma di millenarismo apocalittico, oltre a essere assoggettato al timore della fine del mondo, è punto di partenza verso un’altra realtà, verso una nuova situazione, nel senso assunto dalle continue aperture e stratificazioni della storia, passando così dalle valutazioni che portano lo sguardo su paure e sentimenti regressivi o trascendenti a una visione del presente di un momento di passaggio come cerniera aperta sul futuro (4).
Se ora ritorniamo, con la memoria personale, al tempo recentemente vissuto, sia da chi già era in età adulta, sia da parte di chi viveva una condizione ancora infantile, quali sono state le paure che abbiamo percepito con l’approssimarsi dell’anno 2.000? Forse la più appariscente, al di là di possibili marginali millenarismi odierni, è stata quella del Millennium Bug, un possibile difetto informatico, legato alla non perfetta programmazione dei computer, che avrebbe potuto mandare in tilt i computer (i “calcolatori”, per usare un francesismo) di mezzo mondo, in una visione che appariva come apocalittica, ma che si è rivelata quasi una burla. Non so se la differenza fra l’anno Mille e l’anno Duemila possa essere ridotta a tale immagine, ma con una certa ironia mi piace pensare che la nostra visione millenarista si definisse con questa paura, in fondo minima e ingiustificata, legata a uno degli strumenti che ci aiutano nel vivere, nel lavorare, nel comunicare. Allora, tra l’altro, non ancora così determinante nelle nostre vite quotidiane, come in seguito è diventato.
Di certo, abbiamo attraversato una soglia, che può essere rappresentata da alcune immagini emblematiche della nostra epoca, prodotte nell’arte contemporanea. In esse il senso del passaggio fra due tempi, due luoghi, due situazioni, può assumere diverse conformazioni, riesumando una diversa cultura simbolica.
Tra i molti esempi di elaborazioni che hanno al centro della loro configurazione tematica e iconografica tale concetto di passaggio, di soglia, nelle diverse declinazioni in qui questo può diventare rappresentativo di un’idea di tempo, oltre che di spazio, ne scelgo alcune che hanno una particolare valenza emblematica. A cominciare dal ricorrere di tale immagine nell’opera di Silvio Wolf, che già nel 1980, scegliendo una fotografia scattata in un luogo del Marocco, in cui un particolare gioco di luce e ombra appiattisce lo spazio compreso fra due aperture di diverso carattere – una modulata secondo i criteri dell’architettura mozarabica, l’altra che riprende la più convenzionale scansione rettangolare di una finestra anonima – fa diventare quei due diversi modi di incorniciare lo spazio attraversato dallo sguardo complementari fra loro, in un dialogo fra il qui e l’altrove. Da allora, il riferimento al luogo rappresentato dall’immagine come tramite tra due condizioni, quella del visibile e quella del pensabile, ritorna nel suo lavoro attorno al concetto di soglia, come punto di intersezione fra due stati di potenziali verità. Quello che interessa Wolf, nel concentrare il suo impegno sulla forza simbolica dell’immagine, è indagare attraverso di essa “la sottile linea di confine tra vedere e pensare, la soglia che connette e separa questi due aspetti fondamentali della nostra conoscenza della Realtà. La mia attenzione si concentra sul limite che definisce il nostro rapporto mentale e percettivo con il Reale e quindi sul ruolo cruciale che gioca l’osservatore nella relazione tra ciò che il fotografo ha visto e ciò che lui vede” (5). Una tra le molte, valida a intendere una transizione immateriale, di natura spirituale, è quella del Mirhab, che anche nella sua connotazione religiosa vera e propria produce lo scarto tra la forma fisica e quella traslata della sua presenza.
In realtà, al di là delle qualificazioni simboliche, che hanno nella dimensione del religioso la loro più forte pregnanza, il “passaggio” da una condizione all’altra, da un luogo all’altro, lo compiamo in ogni momento, privato o pubblico, dell’esistenza quotidiana. Esso può assumere, per intervento della coscienza o del modo in cui un poeta o un artista lo percepisce e lo pone sotto gli occhi di un osservatore esterno, una nuova qualificazione, che conferisce al più banale evento della quotidianità una qualificazione filosofica, di matrice esistenziale o esperienziale. Alla Biennale del 2001 Mark Wallinger ha presentato la videoinstallazione Threshold to the Kingdom, consistente nella ripresa a camera fissa, rallentata nel montaggio, delle porte di un aeroporto londinese che si aprono nel momento in cui vengono varcate da qualcuno, che giunge nel “Regno”. Accompagnata da una musica sacra, la sequenza assumeva una valenza fortemente metaforica, interpretando il senso di una transizione che trovava in quell’aprirsi delle porte automatiche una connotazione magica. Quella soglia, interpretabile anch’essa in senso simbolico e quasi religioso, poteva essere considerata una delle rappresentazioni più efficaci del passaggio epocale che si era verificato, tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio, non senza qualche dose di ironia.
Il valore traslato delle riprese di movimenti ispirati a incarnare il senso della transizione come condizione metafisica hanno trovato in un’altra nota videoinstallazione, presentata nel corso di un’altra Biennale di Venezia, nel 2007, la loro più compiuta ed enigmatica espressione. Il riferimento è alla complessa messa in scena di Bill Viola intitolata Ocean without a Shore, composta da più schermi, posizionati allora in corrispondenza degli altari della chiesa di San Gallo, sui quali comparivano in lenta successione persone di varia età che, provenienti da un nebuloso sfondo in bianco e nero, attraversavano una soglia costituita da una cascata d’acqua, assumendo una vivace colorazione che li “materializzava” dopo il passaggio attraverso tale “parete”. Quel “passaggio” dentro e oltre il vivere, o di ritorno alla vita, così pare di potere leggere quel cambiamento di stato che si connotava con le espressioni di stupore, meraviglia, gioia quasi, dava pienezza a una trasformazione visualizzata mediante gli scarni mezzi della rappresentazione realizzata in studio dall’artista americano.
Non voglio spingermi a dire che il cambiamento di millennio possa avere condizionato i soggetti artistici dei primi anni del Ventunesimo secolo, ma all’interno di una continuità di iconografie che potremmo individuare anche in altre epoche e momenti della storia dell’arte, alcune delle più interessanti, a mio avviso, tra quelle prodotte in tempi recenti possono essere lette in questa chiave. Tra queste, una delle più suggestive, nella sua semplicità, è quella che Ilya ed Emilia Kabakov hanno collocato all’interno della complessa elaborazione L’Etrange Cité, realizzata in occasione della loro partecipazione al programma Monumenta, consistente in mostre di grande forza visiva allestite annualmente negli spazi del Grand Palais di Parigi. Qui, nel 2014, i Kabakov hanno creato un percorso che nel suo insieme costituiva un modello di città utopica, fondata su vari stadi o isole, uno dei quali dedicato a una versione di “portali” aperti sull’infinito. In un ambiente a pianta ovale alcuni dipinti di carattere “post-impressionista” mostravano l’apparire in un fluido colore di derivazione monetiana di misteriosi portali quasi confusi in un paesaggio impalpabile, mentre al centro della sala una semplice porta di legno, moderna ed elegante, staccata dalle pareti e spalancata sul vuoto, incarnava il senso di un “attraversamento” che dalla banalità dell’oggetto d’arredo aspirava a illustrare il transito da una realtà a un’altra. Pochi, tra i visitatori, si avventuravano in quell’attraversamento, intimoriti dall’oggetto estetico e incantati dal carattere di forte teatralità che la situazione assumeva. Osservare altri attraverso la porta, più che immaginarsi mentre la si attraversava, diventava un modo di fruirne come di elemento interrogante, più che affermativo.
Ancora, tornando a un esempio precedente, che mette in moto una condizione esistenziale in cui si riflette un rapporto tra sé e il luogo che introduce il tema dell’identità nei confronti dell’immagine, Anna Valeria Borsari aveva inteso porre al centro della sua attenzione il passaggio di condizione temporale in una sequenza di immagini realizzata nel 1977 a Bologna, con il titolo Attraversarsi. In questa, attraverso una serie di riprese fatte da due fotografi da due opposti punti di osservazione, a distanza di un intervallo temporale fisso, l’artista compariva mentre percorreva il percorso rettilineo di un portico della città felsinea, dalla denominazione chiaramente simbolica, il Portico detto “della Morte”, mentre si allontanava da una estremità e si avvicinava all’altra, fino a scomparire comunque, al di qua dell’occhio che la riprendeva, lasciando il lungo ambulatorio vuoto, come era prima del suo apparire. L’autorappresentazione che svanisce nel luogo stesso in cui l’immagine viene ripresa e come diluita diventa, in quel lavoro di matrice fotografica, un modo di riflettere, ancora una volta, sul ruolo della mediazione dell’immagine fotografica, capace di sovrapporre dimensione soggettiva e oggettiva nella sembianza di veridicità inoppugnabile che essa parrebbe affermare.
Dalla soglia, alla finestra, alla porta; ogni transito comporta un percorso, per cui può essere importante sottolineare come un’altra immagine fondamentale di derivazione architettonica per la cultura visiva contemporanea nel suo rapporto con la storia possa essere considerata quella del “corridoio”. Con tale qualificazione possiamo intendere ogni ambiente che funga da collegamento, di limitata funzione dal punto di vista abitativo, se non per la necessaria ragione di mettere in relazione due o più ambienti in cui si conduce il tempo dell’esistenza o quando esso, con il modificarsi della destinazione d’uso di edifici di particolare rilevanza storica, come accade con la trasformazione dei palazzi residenziali in musei, per esempio, assume un ruolo centrale.
Nei termini delle manifestazioni dell’arte, si può considerare che molta arte “ambientale” trovi proprio nella figura del corridoio la realtà più appropriata per rappresentare forme di costrizione, di paura, ma anche la tensione a un superamento della condizione fisica del luogo, oltre che interrogare la struttura formale di un percorso da compiere per una più acuta percezione dello spazio. Sono alcune delle diverse connotazioni che i “corridoi” assumono, divenendo il fulcro dell’attenzione per Bruce Nauman o per Dan Flavin. La concezione del corridoio come spazio di attraversamento che comporta una attivazione fisica, oltre che psicologica, del percorso indotto nell’osservatore (o nel fruitore) riguarda, in modo diverso, le connotazioni dei “corridors” di Nauman, gli ambienti di luce di Dan Flavin, ma anche, ancor prima, le realizzazioni ambientali di Lucio Fontana, alcune delle quali esplicitamente ed efficacemente indirizzate a provocare un percorso che si limita allo spostamento nello spazio, come nel caso del primo Ambiente spaziale del 1949 o in quello realizzato ad Amsterdam nel 1967, con la tripartizione di corridoi invasi da una luce rossa che trasformava lo spazio, fino a diventare un vero e proprio percorso verso un centro emblematico, nell’ambiente realizzato nel 1968 per Documenta, sorta di labirinto bianco, immateriale al cui centro era presente un “taglio” verticale su un pannello isolato. Questi interventi di Fontana, che per certi versi anticipano e affiancano le operazioni ambientali fondate sull’uso di luce che modifica la percezione dello spazio elaborate da James Turrell, hanno inaugurato anche le varianti di carattere strutturale, sviluppate da Gianni Colombo e dagli altri componenti del Gruppo T, oltre che del GRAV o del Gruppo Zero, nella loro attitudine a operare sullo spazio fisico mediante modifiche delle condizioni di percezione e attraversamento. Sviluppate in un arco temporale che va dagli anni Sessanta ai Settanta, in particolar modo, tali manifestazioni sono alle origini di operazioni svolte da autori delle ultime generazioni, come Olafur Eliasson, tese a indagare il senso del “procedere attraverso”, con connotazioni temporali, oltre che ambientali, spaziali e metaforiche.
Dal corridoio e dall’incidenza dell’idea di un percorso da compiere si potrebbe introdurre un altro modello “architettonico” e visivo presente in tutte le culture, ma che ha conosciuto una recente ripresa di attenzione, vale a dire il concetto di labirinto, che ritroviamo nelle grandi strutture di Richard Serra, oltre che essere esplicitamente richiamato dalle proposte del minimalismo, di Robert Morris o di Alice Aycock. Altri labirinti, estremamente complessi nella volontà di richiamare il valore del mito che ne è alle origini e le implicazioni legate alle reciproche poetiche di forme, segni e oggetti, sono stati concepiti da Arnaldo Pomodoro, da Jannis Kounellis e da Claudio Parmiggiani, ricorrendo a uno degli archetipi della conoscenza, della memoria, ma anche della clausura come imprigionamento, ossessione, motivo autoriflessivo. Per questa via, il labirinto può essere inteso come figura allargata dalla sua forma visiva alla sua concezione di meccanismo dell’inganno, come in una installazione presentata dall’artista polacca Alicja Kwade alla Biennale di Venezia del 2017, Weltenlinie, in cui la dimensione simbolica del labirinto era evocata dal ripetersi ingannevole di pareti a specchio e aperture delle stesse dimensioni, rispetto alle quali le pietre colorate, alcuni oggetti d’uso e i visitatori stessi si ritrovavano protagonisti di un rapporto tra presenza fisica e riflessa. Al cuore di quel lavoro era perciò la parete riflettente, lo specchio, che fungeva da materia di costituzione fittizia dell’immagine.
Tutti questi esempi valgono, a mio avviso, a testimoniare come le metafore del passaggio si siano moltiplicate nell’arte dei recenti decenni, trovando in una nuova emergenza del simbolico (o forse nella sua naturale persistenza) una applicazione che può racchiudere il desiderio e il bisogno di rappresentare il senso del passaggio di stato che la dimensione temporale, di cui consapevolmente o meno la connotazione del passaggio di millennio può essere espressione immediata, racchiude.
Anche gli ultimi due esempi ai quali mi piace accennare possono servire a indicare come l’attraversamento può costituire il segno del bisogno di superamento dell’impasse di cui lo specchio è immagine e di un ritorno-evocazione dell’origine, quale punto di rigenerazione del tempo stesso. Mi riferisco in primo luogo alle diverse occasioni in cui Michelangelo Pistoletto ha messo in scena la performance della distruzione dello specchio, mediante un tipo di intervento che non è solo autoreferenziale, ma vale come qualificazione complessa, dove la distruzione e la rigenerazione dell’immagine ha valore liberatorio e creativo, più che iconoclasta. E, a chiusura di questa sintomatica carrellata fra diverse elaborazioni collegate da un filo nascosto che vedono nel “passare attraverso”, reale e immaginari, o la loro connessione ideale, a una delle realizzazioni di portata immediatamente simbolica concepite nei primi anni del nuovo millennio, L’Origine du Monde richiamata da Anish Kapoor nel museo giapponese di Kanizawa, uno dei primi a fregiarsi della definizione di museo dell’arte del “Ventunesimo secolo”. In quell’intervento, che nel titolo richiama il noto dipinto di Gustave Courbet, Kapoor ha riproposto il tema del vuoto metafisico che è al centro del suo lavoro da tempo, attribuendo ad esso, in virtù del rapporto fra titolo e immagine, il carattere di un’apertura sul futuro e sul passato contemporaneamente, interpretando così non solo un carattere astratto, ma radicato nella dimensione del vivere, del rapporto tra esistenza e mistero dell’origine.
Tutti i lavori richiamati condividono, in realtà, la necessità da parte degli artisti interpreti dell’epoca nella quale viviamo di individuare il senso di un racconto del tempo di transizione che ogni rapporto con la contemporaneità propone e che più fortemente può essere sentito nel momento in cui si coglie la percezione del passaggio epocale.
NR. Il testo riporta l’intervento presentato al convegno “Postutto” l’ 11 ottobre 2019.
- Al momento dell’intervento al convegno organizzato dalla Associazione AR.RI.VI. e dalla Fondazione Borsari presso l’Università degli studi di Milano il testo di tale volume era in bozze e nel frattempo è stato pubblicato – cfr. F. Tedeschi, Luoghi di transizione. Forme e immagini di “passaggio”, fra arte e architettura, Scholé (Morcelliana), Brescia, 2020 – anche se i suoi contenuti erano stati oggetto dei due corsi sopra citati. Questo intervento costituisce in certo senso un corollario a quanto svolto in quel volume.
- H. Focillon, L’Anno Mille, Neri Pozza Editore, Vicenza 1998 (trad. di A. Marchi; ed. orig. Max Leclerc et C., Paris 1952), p. 55.
- “Forse la storia non è che una serie di scambi e aggiustamenti tra queste diverse stratificazioni, con dei fenomeni di frattura, che mettono a nudo i segreti della profondità”, Ibid., pp. 76-77.
- “Ogni periodo storico, e persino ogni momento della storia, è il risultato di un incontro tra passato e futuro, ed è forse la proporzione del dosaggio che definisce ciò che chiamiamo presente. Il ‘presente’ dell’anno mille ci mostra nello stesso tempo forme molto antiche e forme destinate a un grande sviluppo futuro, fenomeni di strutturazione che danno vita nuova alla storia e fenomeni di disgregazione che cancellano il passato”, Ibid., p. 79, ad apertura del cap. secondo, La costruzione dell’Occidente.
- S. Wolf, Al di là delle immagini, 2016, ripreso dal sito dell’artista, silviowolf.com, tra gli scritti dell’artista stesso.